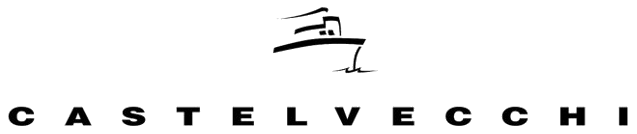Gli anni padovani di Galileo raccontati da Alessandro De Angelis
Dal primo aprile in libreria “I diciotto anni migliori della mia vita” di Alessandro De Angelis. Un romanzo che, poggiando su una rigorosa ricerca storica, gioca sul confine tra fiction e non-fiction e racconta un Galileo poco conosciuto, imperfetto, memorabile, attraverso i diciotto anni scapigliati e burrascosi che Galileo trascorse a Padova e che lui stesso definirà i «migliori di tutta la mia età».
Nell’immagine in homepage “Il ritratto di Galileo” di Justus Sustermans conservato nella Galleria degli Uffici a Firenze. Di seguito un estratto tratto dal romanzo:
Padova, casetta dietro Santa Giustina, 27 settembre 1592
Era una voce giovane, entusiasta, e aveva quella cantilena che non sapeva ancora se sarebbe riuscito, un giorno, ad accettare di buon grado. Seduto in giardino, nel vento del pomeriggio che tirava dai Colli Euganei, Galileo si sentiva chiamare da fuori l’uscio. «Illustrissimo!»: suonava tra l’amichevole e il sottomesso. Dialetto, ritmo, tono. Galileo era un musicista, dopotutto. Quel poco che aveva imparato della lingua veneta nel primo mese a Padova gli fece capire che il visitatore era veneziano, e di buona famiglia. Aprì la porta del cortile e trovò sul prato una carrozza, e davanti a essa un giovane con un viso che gli parve bellissimo. Avrà avuto vent’anni, era ben vestito e ben rasato, aveva un fisico forte e grandi occhi intelligenti che agitava qua e là alla maniera dei folli. «Maestro» disse, «volevo avere l’onore di conoscervi. Mi chiamo Giovanni Francesco Sagredo, e vengo apposta da Venezia». Galileo era combattuto tra la curiosità di parlare finalmente con una persona che sembrasse interessante – a Padova non ne aveva conosciute molte – e l’angoscia che sempre lo prendeva in quei giorni. Alla fine disse: «Ho poco tempo, ma mi fate piacere se entrate a bere un bicchiere.
Ho portato due botticelle da Firenze, e purtroppo le sto finendo più velocemente di quanto pensassi. Non ho ancora trovato un buon vino di qui». Sagredo lo seguì dimenticandosi del cocchiere, ed entrò nel giardino; Galileo chiuse la porta e lo invitò a sedere. Sul tavolo c’erano varie tazze; ne sciacquò una con l’acqua di una caraffa, buttò a terra il risciacquo e versò del vino rosso da un’altra caraffa. Era bruno e scuro. «Per forza non ne trovate che vi piaccia: qui il vino migliore è bianco, a volte un po’ frizzante, e quello buono è dolce; d’estate è bello berlo fresco». Galileo sorrise: «Allora dovrò rassegnarmi. Aristotele diceva che i grandi uomini bevono vino rosso, e due buoni esempi erano lui e il suo maestro Platone; io umilmente sposo la sua opinione. Che cosa volete da me?».
«Maestro, la vostra fama vi ha preceduto. Il consiglio di saggi che vi ha scelto per la cattedra si riuniva spesso a casa di mio padre a Venezia, e ho sentito parlare dei vostri meravigliosi esperimenti sulla natura. E sono anche appassionato di musica, e ho letto il libro di vostro padre, e quando penso al fatto che siete qui mi emoziono; vorrei stare con voi e imparare a diventare un filosofo della natura». Mentre lo diceva i suoi occhi brillavano, forse per il sogno che andavano figurandosi, ma in quella luce si distingueva anche un po’ di perfidia. Galileo ne provò simpatia. «Io però ho molto da fare ora. Fra qualche settimana terrò la mia prima lezione, e su quella lezione verrò giudicato. Con tutti i preparativi che mi occorrono, non so nemmeno dove trovare i libri, qui a Padova, a parte la biblioteca del mio ospite Pinelli, che non voglio disturbare sempre. Ho bisogno di concentrazione, concentrazione, per cercare dentro di me». «Lo so. Scusatemi ancora». Sagredo parlò a parole accelerate. Prese il bicchiere e lo bevve di un fiato. «Non mancherei per nulla al mondo alla vostra lezione. In futuro, se me ne darete l’opportunità, vi mostrerò le biblioteche veneziane. Anche se l’università è a Padova, tutti i suoi strumenti sono a Venezia, e ce ne sono tanti, vedrete, e biblioteche più ricche di quella di Pinelli. Vi ringrazio per il tempo che mi avete concesso». Galileo provò ancor maggiore simpatia. Sagredo corse via senza neppure aspettare una risposta al suo saluto. Salì sulla carrozza e diede ordine di partire. Si sentì strano: il giardino si allontanava, e lui, come in un sottofondo del pensiero, sentiva che sarebbe stato tra i protagonisti di una storia che avrebbe cambiato il mondo. Galileo si rimise sulla lezione, ma fu distratto da altri pensieri, più terreni. Centottanta ducati all’anno non erano granché, e aveva già chiesto all’università un anno di anticipo. Proprio lui, che a ogni prezzo avrebbe voluto evitare la responsabilità, si sentiva all’improvviso responsabile per la sua famiglia. Con il padre che era mancato da un anno, sua madre non aveva smesso di ricordarglielo: avrebbe dovuto aiutare le economie della famiglia che aveva lasciato a Firenze. Il fratellino Michelangelo, di undici anni più giovane, era certo un musicista di talento, ma egli sapeva dall’esperienza del padre che il talento nella musica non era garanzia di guadagno. Sarebbe dovuto davvero diventare medico? Ma quanto l’arte musicale e la geometria erano più stuzzicanti della medicina. Certo, aveva tenuto la musica come passione, perché mai avrebbe potuto competere con suo padre sul piano professionale. Sentiva comunque che applicandosi a discipline tanto aliene della musica, come certamente era la medicina ma in parte anche la geometria e la filosofia naturale, avrebbe appannate quella freschezza ed eleganza di gusto che servono a un musicista per eccellere. Tutti continuavano a dirgli che era rimasto valente nella musica, ma egli sentiva che non avrebbe più potuto essere musicista. Si confrontava sempre con suo fratello Michelangelo, che invece aveva mantenuto il suo spirito di artista a prezzo di un distacco totale dalle cose concrete. Quando suonavano assieme il liuto sentiva che Michelangelo percepiva cose, luci e sensazioni che a lui diventavano chiare solo dopo averle sentite da suo fratello. E il padre in punto di morte aveva donato a Michelangelo il liuto più bello: questo aveva un significato. Bene, ora si trovava in terra straniera, a sedere su una cattedra che molti avrebbero sognato, una delle migliori di tutta l’accademia mondiale, in una delle città universitarie dalla cultura più vivace. Padova aveva circa quarantamila abitanti, e l’università contava circa centocinquanta professori e milleduecento studenti, molti stranieri, che potevano risiedere in alloggi privati, o a pigione dai professori, o in collegi religiosi o nazionali. Le nazioni erano ventitré, e più che a Stati corrispondevano a comunità: partendo dalla più numerosa, la tedesca, c’erano poi la polacca, la boema, l’ungherese, la provenzale, la borgognona, l’inglese, la spagnola, l’oltremarina (cioè degli slavi), la scozzese, la romana, l’italiana, l’anconitana, la lombarda, la milanese, la genovese, la toscana, la veneta, la trevisana, la friulana, la dalmata, la piemontese e la padovana stessa. Molte nazioni avevano biblioteche proprie, all’incremento delle quali provvedevano con doni e omaggi gli scolari stessi; fra queste si distinguevano per abbondanza di libri e codici la tedesca e la polacca. Collegi pii e fondazioni permettevano di dedicarsi agli studi anche ai meno abbienti. Collegi e nazioni erano perlopiù posti nel triangolo tra San Biagio, Santa Sofia e San Francesco, e in quella zona erano spontaneamente nate nel tempo molte osterie e qualche bordello; sicché in questo quartiere si vedevano girare anche molti professori. Il governo veneto lasciava piena libertà agli scolari: se non s’immischiavano di politica e non agitavano questioni religiose potevano mantenersi fedeli alle patrie consuetudini e vivere come meglio volevano, a differenza di quanto avveniva a Bologna dove gli stranieri erano costretti a italianizzarsi e a fare professione di fede cattolica. Il capitanio, prefetto che amministrava per conto della Serenissima la città, tollerava che gli studenti si bastonassero tra loro, cosa che peraltro accadeva spesso, a condizione che non si causassero danni permanenti. La vicinanza a Venezia, che aveva centocinquantamila residenti e offriva un sistema postale avanzatissimo, rendeva facile procurarsi in tempi brevi libri e documenti da tutta Europa. Nella cattedra di matematica erano compresi gli insegnamenti di geometria, astronomia, filosofia naturale o fisica, ingegneria militare e fortificazione. La cattedra di astrologia era stata abolita a Padova solo da pochi anni, a seguito di pressioni del papa che erano state sopportate con grandi mal di pancia; comunque ci si aspettava che il matematico astronomo fosse un po’ anche astrologo. L’astrologia partiva dal concetto che gli eventi terreni e i fenomeni celesti fossero legati da stretti vincoli, e che le catene di cause ed effetti fossero continue nell’Universo; non era strano che Galileo vi fosse, almeno in parte, consenziente. L’astrologia richiede grande tecnica e capacità di calcolo, e gli illustri di Toscana consultavano Galileo con totale fiducia, in molti casi chiedendo oroscopi e previsioni, in particolare medici e giuristi, che da un oroscopo ben fatto potevano essere aiutati rispettivamente nelle loro diagnosi e nelle loro sentenze. Nonostante l’onore e la gloria che ne derivavano, il suo stipendio a Pisa era insufficiente a soddisfare tutti quelli che si aspettavano qualcosa da lui. Sua sorella Virginia, di nove anni più giovane, aveva fatto un anno prima un buon matrimonio con tale Benedetto Landucci di Firenze, di famiglia di mercanti che aveva avuto fortuna, tanto che il padre di lui era stato per un anno ambasciatore del granducato presso il papa, e nonostante la professione non sembrava troppo rozzo. Landucci aveva chiesto una dote di mille fiorini; il padre Vincenzo prima di morire gliene aveva dati i primi cinquecento, sicché gli altri cinquecento avrebbe dovuto pagarli Galileo. Cinquecento fiorini valevano cinquecento ducati (da qualche anno il doge di Venezia e il granduca di Toscana si erano accordati per questa equivalenza che semplificava enormemente le operazioni commerciali tra i due Stati), e corrispondevano a quasi tre anni del suo salario. Sapeva che a Padova avrebbe potuto guadagnare molto di più se fosse diventato un professore di grido, con molti studenti, e se fosse riuscito a ingraziarsi l’ottantottesimo doge, Pasquale Cicogna. Ma gli era stato detto che non era facile accedere a Cicogna, un ottantatreenne schivo e riservato. Per il momento la via possibile al successo era una soltanto: una memorabile lezione inaugurale.
© Lit edizioni S.a.s.