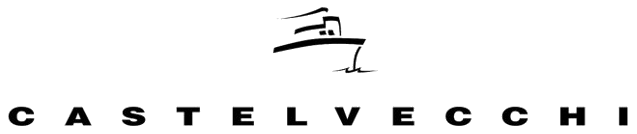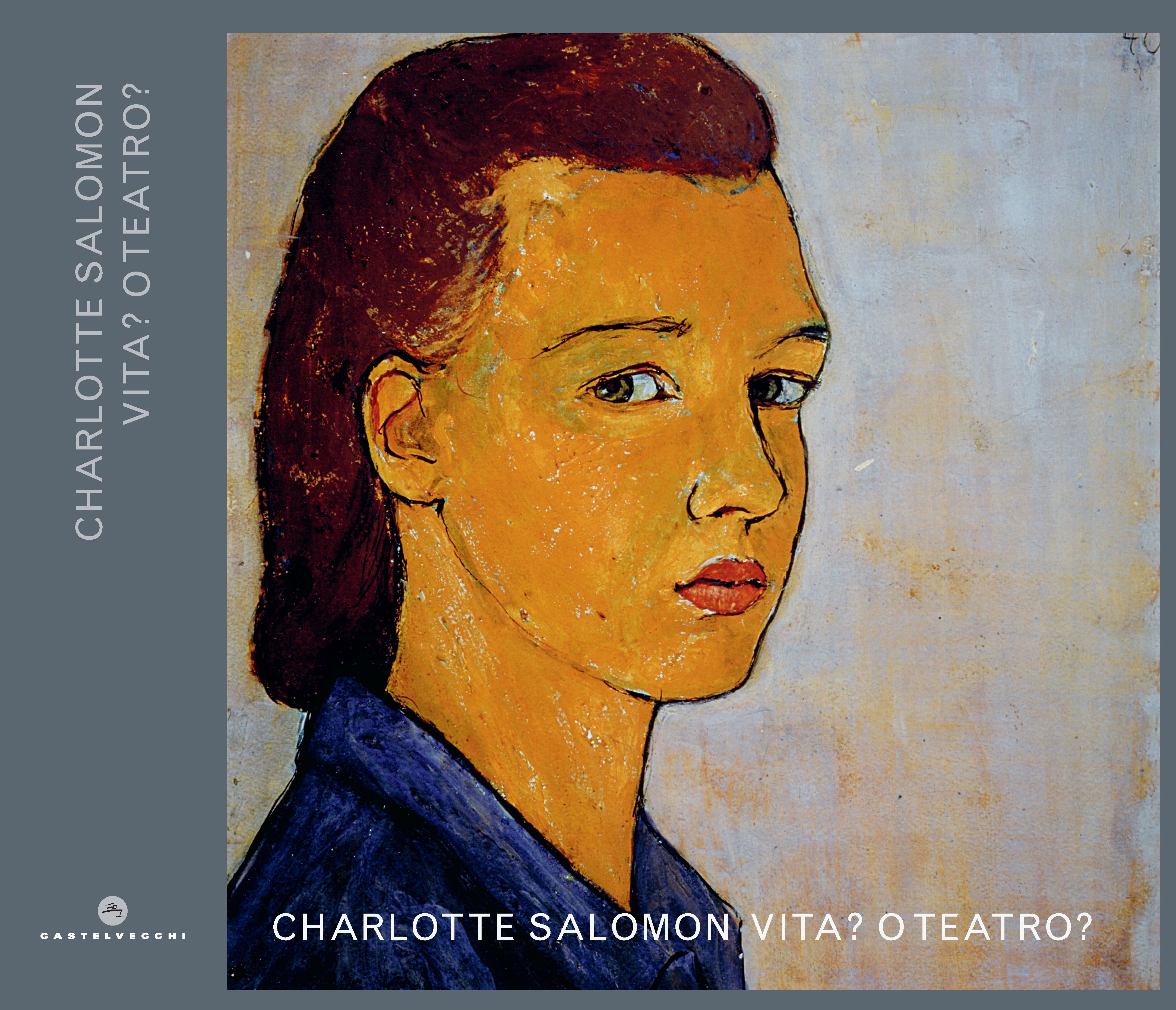“Il villaggio di Stepancikovo e i suoi abitanti” di Dostoevskij
Dalla prefazione di Erri De Luca
Introdurre un’opera di Dostoevskij: una pulce che descrive un gigante. Per bene che le vada ne copre centimetri. Intanto l’evidenza: leggere lui è il piacere puro.
Pubblichiamo un estratto dal libro “Il villaggio di Stepancikovo e i suoi abitanti“ di Dostoevskij nella traduzione di Miriam Capaldo.
Mio zio, il colonnello Egòr Il’ìc Rostanev, quando si ritirò dal servizio, si trasferì nel villaggio di Stepàncikovo, che aveva appena ricevuto in eredità, e vi si sistemò così bene che somigliava a un proprietario che avesse passato tutta la vita nelle sue terre e non se ne fosse mai allontanato. Ci sono nature pienamente soddisfatte d’ogni cosa e capaci di abituarsi a tutto, e tale era per l’appunto quella del colonnello in congedo. Era difficile immaginarsi un uomo di indole più tranquilla e più accomodante. Se a qualcuno fosse venuto in mente di chiedergli di portare una persona sulle spalle per un paio di verste, il colonnello forse l’avrebbe fatto. Era generoso al punto che sarebbe stato pronto a dare ogni cosa a chi semplicemente gliel’avesse chiesta, e addirittura a dividere la sua ultima camicia con il primo che ne avesse manifestato il desiderio. Era di aspetto atletico, alto e armonioso, con guance rosse, denti bianchi eburnei, folti baffi castano-scuri, una voce forte e sonora e una risata aperta e fragorosa, parlava a scatti e in modo precipitoso. All’epoca aveva una quarantina d’anni, e tutta la vita, a partire più o meno dai suoi sedici anni, l’aveva passata da ussaro. Si era sposato molto giovane e aveva amato perdutamente la moglie, che però era morta, lasciando nel suo cuore un ricordo indelebile e pieno di gratitudine. Infine, dopo aver ereditato il villaggio di Stepàncikovo, che portò il suo patrimonio a seicento anime, lasciò il servizio e, come si è già detto, si stabilì in campagna insieme ai suoi figli: Iljusa di otto anni (la cui nascita era costata la vita alla madre), e Sàšen’ka, la figlia maggiore, una ragazza di quindici anni che dopo la morte della madre era stata educata in un collegio a Mosca. Ma la casa di mio zio ben presto divenne simile all’arca di Noè. Ecco come ciò accadde. Al tempo in cui Egòr Il’ìc, ereditata la proprietà, andò in congedo, sua madre era rimasta vedova per la seconda volta. Quando mio zio, sedici anni addietro, era ancora un semplice alfiere e ciò nondimeno meditava già di sposarsi, lei aveva sposato in seconde nozze un generale, divenendo così la generalessa Krachòtkina. A lungo lei si era rifiutata di dare il suo consenso al matrimonio del figlio, aveva versato lacrime amare, lo aveva rimproverato di essere un egoista, ingrato e privo di rispetto e gli aveva dimostrato che la sua proprietà, di duecentocinquanta anime, era appena sufficiente per il mantenimento della sua famiglia (e cioè di sua madre e di tutto il suo quartier generale di parassite, botoli, spitz, gatti cinesi e così via). Poi, nel bel mezzo di tutti questi rimproveri, rimbrotti e strilli, all’improvviso, e in maniera del tutto inattesa, era stata lei stessa a sposarsi: prima del matrimonio di suo figlio, e nonostante i suoi quarantadue anni. D’altra parte, anche allora lei aveva trovato un pretesto per accusare il mio povero zio, dichiarando che, se lei prendeva marito, era unicamente per potersi assicurare quel rifugio nella vecchiaia che suo figlio, egoista privo di pudore qual era, le negava, avendo osato concepire l’imperdonabile insolenza di mettere su casa per proprio conto. Io non sono mai riuscito a sapere il vero motivo che aveva spinto un uomo apparentemente così giudizioso come la buon’anima del generale Krachotkin a prendere in moglie una vedova quarantaduenne. Si deve supporre che il generale la credesse ricca. Altri pensavano ch’egli semplicemente avesse bisogno di una governante, come se all’epoca avesse già presentito la sequela di malattie che, nella vecchiaia, non gli avrebbe dato tregua. Una cosa è certa, che il generale per tutta la durata del matrimonio nutrì una profonda mancanza di rispetto per sua moglie, che derideva con velenoso sarcasmo ogni qual volta gli si presentava l’occasione. Era un uomo strano. Poco istruito, niente affatto stupido, disprezzava tutti con determinazione, era del tutto privo di princìpi, rideva di tutto e di tutti e, da vecchio, a causa delle malattie, che erano conseguenza di una vita non proprio ordinata e virtuosa, era diventato malvagio, stizzoso e crudele. Nella sua carriera militare aveva avuto fortuna. Tuttavia era stato costretto, e in malo modo, a congedarsi in seguito a uno “spiacevole incidente”, riuscendo a malapena a evitare il processo, ma rimanendo senza pensione. Questo lo aveva definitivamente esasperato. Quasi del tutto privo di mezzi, visto che possedeva solo un centinaio di anime in condizioni pietose, incrociò le braccia e per tutto il resto della sua vita, per ben dodici anni, non si informò mai di che cosa vivesse, né di chi lo mantenesse; e intanto pretendeva la vita comoda, non riduceva le spese, non si faceva mancare la carrozza. Presto perse l’uso delle gambe e, gli ultimi dieci anni, li passò su una comoda poltrona, spinta, quando era necessario, da due mastodontici servitori, che da lui non udirono nient’altro che ingiurie di tutti i tipi. La carrozza, i domestici e la poltrona li manteneva il figlio poco rispettoso, che mandava alla madre quel poco che gli rimaneva, e che metteva sulla proprietà ipoteche su ipoteche, rinunciando al necessario per sé, contraendo debiti pressoché impossibili da saldare con il modesto patrimonio di cui allora disponeva, e nonostante ciò gli rimase sempre appiccicata addosso la nomea di figlio egoista e ingrato. E mio zio aveva un carattere tale che alla fine cominciò a credere egli stesso di essere egoista, sicché per autopunirsi e per non essere egoista mandava sempre più soldi. La generalessa aveva una venerazione per il marito. Tuttavia quello che le piaceva più di tutto era che lui fosse generale e lei, grazie a lui, generalessa. Ella aveva a sua disposizione la metà della casa in cui viveva e in questa, per tutto il tempo della semi-esistenza di suo marito, poté prosperare in compagnia di parassite, pettegole e bigotte. In città era una delle persone più in vista: gli intrighi, gli inviti a fare da madrina di battesimo e di nozze, le partite a préférence da un copeco e l’universale rispetto per il suo generalato la ricompensavano pienamente del suo stato di sottomissione domestica. Le gazze della città venivano a farle i loro resoconti e, sempre e dovunque, le veniva riservato il posto d’onore. In una parola, dalla sua condizione di generalessa aveva ricavato tutto quello che aveva potuto. Il generale non si intrometteva in nessuna di queste faccende, e tuttavia in presenza di altre persone irrideva la moglie senza alcun ritegno, così per esempio si chiedeva perché mai avesse sposato una «tale patita di ostie consacrate». E nessuno osava contraddirlo. A poco a poco tutti i conoscenti lo abbandonarono, e tuttavia aveva bisogno della compagnia: amava fare due chiacchiere, discutere un po’, gli piaceva avere sempre qualcuno di fronte ad ascoltarlo. Era un libero pensatore e un ateo alla vecchia maniera, e perciò amava discutere anche di nobili argomenti. Ma gli ascoltatori della città di N*** non amavano i discorsi elevati, sicché si fecero sempre più radi. Avevano provato a fare delle partite domestiche di whist-préférence, ma il gioco terminava di solito in tali escandescenze da parte del generale che la generalessa e le sue parassite, atterrite, accendevano ceri, innalzavano preghiere, facevano predizioni con le carte o con le fave, distribuivano panini in carcere e aspettavano tremanti l’ora pomeridiana quando bisognava ricominciare a giocare e a subire, a ogni singolo errore, strida, strilli, ingiurie e, poco ci mancava, anche delle percosse. Quando qualcosa non gli andava a genio, il generale non provava imbarazzo di fronte a nessuno: strillava come una donnicciola, imprecava come un cocchiere, e a volte, strappate le carte e sparpagliatele sul pavimento, cacciava via i suoi compagni di gioco, e si metteva persino a piangere per la stizza e la collera, e non per altra ragione, ma perché qualcuno aveva giocato un fante invece di un nove. Alla fine, a causa della vista che gli si era indebolita, ebbe bisogno di qualcuno che gli leggesse. In quel preciso momento fece la sua apparizione Fomà Fomìc Opiskin.
© 2021 Lit edizioni s.a.s.
NOTA AL TESTO PUBBLICATO ONLINE: NON è STATO POSSIBILE RIPRODURRE IN QUESTA PAGINA IL SEGNO DIACRITICO PRESENTE SU ALCUNE LETTERE IN QUANTO NON RICONOSCIUTO DAL PROGRAMMA.